III.
Collana Cibele
14. Roccabascerana
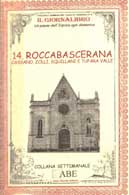
Cassano, Tuoro, Zolli, Squillani e Tufara Valle
Archeologia, Storia e Personaggi
Il territorio della Valle Caudina, che comprende
anche il perimetro di Roccabascerana, era abitato
già nell’Età della Pietra. Affondando le sue origini nella civiltà osco-sannita,
ha risentito del vicinissimo influsso romano, ma, come vedremo, si svilupperà
solo con i Longobardi ed i Normanni. Nel frattempo, le tribù superstiti dei
nostri Sanniti-Caudini, dovettero rifugiarsi sulle colline del Partenio.
In questa parte dell’Irpinia, nel loro piccolo,
sono stati così innumerevoli i cambiamenti della storia che è difficile individuare
un Oppidum, cioè il posto dove si insediarono gli abitatori della zona per
sfuggire ai Romani, ma per nostra convinzione potremmo farlo nascere nella
zona a valle, lungo la via nazionale Appia, tra Roccabascerana e San Martino.
Qui sono innumerevoli le tombe a cappuccina scoperte dai contadini che ne
hanno riutilizzato i mattoni per arginare il torrente San Giovanni che si
immette nel Serretelle. Non avendo elevati riscontri di ritrovamenti pratici,
relativi a muraglioni, né ulteriori aiuti provenienti dalla toponomastica,
potrebbe anche non esserci mai stato un oppido, più o meno stabile, ma solo
una necropoli, in quanto i Sanniti del Distretto di Caudium erano stati decimati
e seppelliti, dai superstiti, in necropoli negli stessi luoghi ove avvenivano
anche piccole battaglie. Con un pizzico di ottimismo facciamo comunque nascere
il nostro oppido, che non ha nulla a che vedere con i templi osci dedicati
ad Opi sparsi ovunque nell’intera Opicia, proprio a valle, al confine tra
Rocca, San Martino e Montesarchio, in località Saffota Vetere. Fin dal tempo
di Federico II, il suffeudo di Saffota Vetere era posseduto dalla famiglia
Santarcangelo di Montesarchio. A quel tempo, questo lembo ricadeva in territorio
di San Martino, alla contrada Toro, e confinava con l’altro feudo della Mensa,
antica proprietà dei Del Balzo di Pietrastornina. In quei luoghi c’erano redditi
con terziaria, fittati cioè ai contadini in cambio della terza parte del raccolto,
con diritto di patronato della Chiesa, cioè cum jus patronato seu presentandi
del beneficio dell’Culegia di S.Bartolomeo de saffota ius patronato di detti
feudi.
A generare il nostro abitato civile e militare di Oppidum,
così come è accaduto per Quadrelle, Alfedana (Sant’Angelo a Scala), Trasmonte
(Avellino) o Oppidum Vetere (Caposele), non poterono che essere stati dei
popoli vissuti ai tempi dei Romani, cioè i Sanniti-Caudini. I Sanniti non
costruivano mai grandi città, preferendo dei villaggi per potersi più facilmente
muovere dai campi alle montagne, come nel caso di Boviano, Sora, Canosa, Lucera,
Sepino e la nostra Caudium. Le abitazioni erano dunque provvisorie, sorrette
da povere travi ricoperte di tegoloni a bordi rialzati, quasi sempre all’interno
di due cinte murarie, l’una nell’altra, o, come nel caso di un’altra Alfedana,
di addirittura tre, le cosiddette mura ciclopiche.
L’ampia vallata, che da Airola si estende fino a Roccabascerana, era il
Distretto di Caudium, che diede nome alla Valle e ai popoli caudini che l’abitarono
ai tempi dei gloriosi Sanniti. Errano coloro che identificano Caudio solo
con Montesarchio perché fu ben determinato dall’Antonino nel suo antico Itinerario
nel quale descrive il Distretto a 11 miglia da Benevento, ossia i 18 chilometri
che intercorrono tra Benevento e la Valle Caudina, essendo il miglio romano
1478 centimetri. Del resto, i ritrovamenti di resti sparsi un po' ovunque,
confermano oggi questa antica tesi. Caudio era un distretto importante, ai
laboriosi tempi dei Sanniti, che aveva disposto tutt’intorno una corona di
molti templi, are e diversi oppidi, e quindi anche il nostro. Diciamo quindi
che l’oppido della zona di Roccabascerana-San Martino fu successivo alla strage
delle Forche Caudine e che, l’esigenza di abbandonare -ma non troppo- le piane
vere e proprie e di rendere gli iniziali insediamenti di transumanza più stabili,
si richiese dopo che i Romani cominciarono ad invadere il Sannio, spingendo
quelle popolazioni a fortificarsi - ma non sempre sulle cime dei monti - in
grandi recinti, per contenere case, uomini e greggi.
L’Oppidum che ipotizziamo in territorio dell’attuale Roccabascerana-San
Martino, questa sorta di colonia fortificata, deriverebbe quindi da un avamposto
recintato, ad opera di un insediamento stabile sito sulle pendici del monte,
entro il quale le comunità di quei tempi si rinchiusero per tentare di resistere
all’occupazione romana, più o meno identificabile con Saffota Vetere, una
piccola località oggi in territorio di Montesarchio. La conferma di questa
ipotesi tutta nostra verrà solo quando si ritroveranno le mura, gli ambienti,
o solo la cinta posta a guardia dei casamenti. Dovrà però trattarsi di blocchi
di pietra non lavorati, messi su l’uno sull’altro, in modo da tenersi fermi
con il di loro stesso peso. I cocci ritrovati, il vasellame, i pesi per telaio,
statuine ed anfore sono indiscutibilmente di Età Romana. Ma si tratta, almeno
per il momento, solo di una piccola necropoli di una ventina di tombe scavate
negli ultimi tempi per interessamento dell'attuale sindaco Natalino Renna.
A dire degli studiosi è in relazione con un insediamento dell’Età Romana,
posto appena più a monte, databile dalla fine della Repubblica a quella dell’Impero.
E' facile però incorrere anche in errori storici. Nell’ottobre del 1983, i
carabinieri, segnalarono per esempio una tomba ben costruita in tegolame di
reimpiego e malta appena saccheggiata a Rotondi, localizzata fra il Cimitero
e la Madonna della Stella. Rilevamento insolito che, in questo caso, certamente
non riguarda nè i Romani, né i Sanniti ed è indiscutibilmente del periodo
Longobardo.
Intanto, senza ritrovamenti dai precisi connotati, andare oltre è impossibile,
anche perché era politica delle Aquile distruggere le memorie dei popoli vinti
più volte. Questo piccolo Oppido, dopo le guerre tra Sanniti e Romani, seguì
la sorte di tutti gli altri. Da ciò che rimase di esso, non tanto gli abitatori,
quanto i patrizi romani della Colonia caudina, ne fecero erigere degli altri,
dei nuovi Oppidi appunto, che forse chiamarono Starze, delle ville rustiche
a guardia dei loro fondi, piccole circoscrizioni, in cui era stato suddiviso
il territorio conquistato, facenti parte di una delle province, il Distretto
di Caudium, finite sotto il dominio delle Aquile. Diciamo allora che si tratta
di ville rustiche, dette Starze, costruite non prima di aver tracciato un
selciato, una via pubblica che le collegasse, nato dalla fantasia di chi a
tutti i costi le vuole unire. Ma è soltando parlando delle Starze di Mercogliano,
delle Starze di Summonte, dell’ex Oppido di Sant’Angelo a Scala, della Starze
di Pietrastornina, della Starza di Tuoro di Roccabascerana che riusciamo a
collegare con una semicirconferenza Monteforte con lo Stretto di Balba, facendo
nascere una strada in direzione di Benevento, o snodandola in Valle Caudina,
verso il Distretto di Caudium, non prima di essere passata per Terranova-Fossaceca,
le tombe e il Tempio romano di Arpaise e Paunia, esistita per certo, presumibilmente
proprio tra Pietra-Pannarano-Rocca-San Martino. Una strada che, di villa in
villa, andava a congiungersi all’Appia Beneventana, dopo essersi incrociata
con l’altra via romana proveniente da Abellinum-Prata-Altavilla. E’ lungo
questo tratto che nacquero dei villaggi romani, vici o pagi che siano, se
non proprio un'altra Colonia romana, affidata a più patrizi che, per prima
cosa appunto, si facevano costruire la loro villa. I ritrovamenti in località
Guerrere di Squillani di lucernari sannitici non possono che confermare la
presenza di una villa o di una necropoli; quelli in località Severini, sempre
a Squillani, hanno invece dato alla luce un lare romano (esposto a palazzo
municipale), nella proprietà dell'ex prefetto Rossi, a testimonianza della
presenza certa di una villa nel sottosuolo. E di villa rustica o di fornace
a circa un metro e mezzo di profondità si parla sempre per i ritrovamenti
di Guerrere. La nostra starza è poi ben definita ancora oggi in località Tuoro.
Le Starze rappresentano per noi la nuova organizzazione
politica e sociale del territorio ad opera dei Romani. Non sappiamo come,
non sappiamo di preciso quando. E’ però certo che i Romani erano dei mostri,
capaci come furono, di costruire la fantastica opera dell’acquedotto di Serino
che giungeva - un minutino - fino alla cisterna-piscina Mirabilis di Miseno
per soddisfare le esigenze delle flotte di stanza nel lago Mare Morto di Bacoli,
nel limbo costiero più vicino all’isola di Procida e di Ischia.
Ma se la nostra tesi delle ville abitate è infondata,
dove andarono a finire tutti gli abitanti della zona dopo la sconfitta coi
Romani? Non resterebbe che un’altra ipotesi, quella di una sola grande città:
Caudium. Una grande, immensa, splendida Città di cui non conosciamo assolutamente
niente, né niente possiamo immaginare. Contrariamente alle Starze, che sappiamo
essere esistite in punti ben determinati. Azzardiamo quindi qualcosa in più
sulle Starze, convincendoci che, quasi sicuramente, servirono anche da riparo
a legionari e postali che si spostavano da città a città romana, assumendo
le sembianze di ville, delle ville-masserie appunto, fulcro amministrativo
degli appezzamenti terrieri e montani che mantennero più o meno le divisioni
che riscontreremo con le corti longobarde, in alcuni casi affidate anche ai
sacerdoti. Ne è esempio lampante anche la zona dell’originario Oppidum Vetere,
in località Preta (anticamente Pareta dal nome dell’antica muraglia ivi esistente)
di Caposele, da dove proviene una importante lapide dei tempi di Domiziano,
che si fa risalire alla tribù Galeria, sulla quale fu scoperta un’iscrizione
dedicata a Silvano, dio dei boschi, risalente al I secolo dC, in cui si fa
menzione a quattro fondi (Giuniano, Lolliano, Percenniano e Statulliano),
con villa rustica su ognuno di essi, donati come voto (Silvano: sacrum voto...).
A dire di Mommsen, il voto, fatto alla buona salute di Domiziano, era di un
certo Lucio Domizio Faone per costruire, alle falde del monte Oppido, un tempio
sacro a scopo di culto da affidare ai maestri che facevano parte del collegio
dei sacerdoti di Silvano che dovevano essere mantenuti con i proventi dei
fondi in donazione, fornendogli gratuitamente legna ed aqua proveniente dalle
stesse ville rustiche esistenti entro i confini. Questi sacerdoti, dal canto
loro, avevano obbligo di organizzare cinque feste all’anno: le calende di
gennaio, la nascita dell’imperatrice Domiziana l’11 febbraio, la ricorrenza
delle feste rosali del 20 giugno, il 27 giugno giorno dedicato al dio Silvano
e il 24 ottobre nascita di Domiziano. Ai banchetti sarebbero intervenuti quelli
che facevano parte del collegio con a capo un presidente annuale per garantire
lo svolgersi regolare delle cerimonie. Intorno al tempio dedicato a Silvano,
accessibile a tutti per una via pubblica, un parco avrebbe fatto da riserva
per gli animali da sacrificare.
Con questo esempio, il nostro pensiero si ferma
al Tempio di Arpaise e ad una Preta di casa nostra (Pietrastornina, alias
Pretae Sturminum, Penna Stornina e, forse, detta Alta Coda, ovverio Alta Cauda
che non è Altavilla). Ma siamo nel campo delle ipotesi. Come quelle che potrebbero
venire sui fondi guardati dalle Starze, denominandoli Merculiano, Marzano,
Alfedano, Pannarano, Bascerano... prendendo essi origine dalla Starza, dal
Patrizio, dalla sua villa o dall’ara ivi eretta per contraddistinguere i territori.
Per nostra convinzione abbiamo fatto nascerne
qualcuno anche ai piedi del Partenio, nei pressi dei ritrovamenti delle strutture
murarie e materiali architettonici che testimoniano una presenza anteriore
al III secolo aC, relativamente a Ville rustiche esistenti nella zona di Valle
e di Castello di Cervinara, e presso le frazioni Curielli e Santo Stefano,
risalenti tra il I ed il III secolo dopo Cristo. In questa ottica potremmo
vedere l’origine dei primi insediamenti umani per dissodare i fondi affidati
al patrizio che avrebbe avuto villa da queste parti. Sui latifondi, suddivisi
fra i patrizi romani che avevano combattuto e vinto i Sanniti, erano nate
dunque delle vere e proprie ville coloniali a vista o a guardia anche di una
strada principale come l’Appia. Fra i segni del passato romano abbiamo infine
le tombe dei patrizi, costruite sui colli più alti (è il caso di quella esistente
sotto l'Appia presso l'Asl di Montesarchio e di quella accertata sotto il
cimitero di Bonea); oltre le colonne e le pietre miliari, sempre lungo grandi
strade come l’Appia e qualche sua diramazione.
Nei pressi di questi sconvolgimenti dell’aspetto
naturale del territorio (pagi o vici come Paunia, Caudium, Alfedana, i vari
Oppidi sanniti tra cui Saffota Vetere, Starze come quella di Tuoro, Civitas
romane come Abellinum, Abella, Ville rustiche patrizie come quella di Cocceo
o di Squillani, Tombe e Templi), e più specificatamente sui resti degli stessi,
le civiltà si sono sovrapposte alla meglio nei secoli, scegliendo ora una
Villa, ora un Oppido, ritornando casomai alla Starza, o facendo tappa su un
tempietto.
Le poche tribù sannitiche sopravvissero così,
con la pastorizia e la caccia, negli anni più bui, dal 300 al 500, finché,
non furono accolte nelle braccia della Chiesa di Benevento, ovvero semplicemente
restando nei territori che abitavano, dove si era fatto largo la giurisdizione
di un potere temporale deciso a proteggerle.
In questo periodo, Benevento, divenuta Città della
Chiesa di Roma, insieme alle sue Terre Beneventane, dove il territorio di
Roccabascerana ricadeva, passava in qualche modo fra le Terre di Gerusalemme,
o di Bisanzio, affidate ai primi Longobardi alleati, come nel caso di Alboino,
che erano già da queste parti. Situazione politica che portò alla nascita
di dipendenze delle fondazioni ecclesiastiche beneventane nel territorio circostante
la Città. Quando poi l’ondata barbarica si fece più violenta e i Longobardi
più numerosi, l’occupazione delle nostre Terre Beneventane portò, nel 570,
alla nascita del Ducato di Benevento (che durerà fino al 1074), con Zotone,
riconosciuto dalla Chiesa Beneventana.
Ritorniamo allora agli ordini religiosi di origine a noi ignota, presumibilmente
benedettina, che provvidero ad inviare dei monaci per costruire Cappelle o
eremi nelle Terre Beneventane per meglio conoscere ed eventualmente amministrare
i propri territori. Si andarono in effetti a delimitare i primi beni donati
da nuovi e vecchi patrizi, anche discendenti da famiglie romane, in vita come
in morte. Del resto, le pergamene relative ai primi appezzamenti di questa
zona riguardano monasteri importanti più vicini a Roma, come quelli di Cassino
e di Farfa: proprietà troppo lontane (per essere sfruttate) che permisero
gli scambi con fondazioni ecclesiastiche, più vicine a noi, nate nel mentre
a Benevento o a Cava. I territori del Partenio, della Valle Caudina e della
Valle del Sabato si ritrovarono così nelle mani del monastero femminile di
Santa Sofia, dell’Arcivescovado, e del monastero di San Modesto di Benevento,
ma non prima di essere già passati per altre fondazioni "esterne" al nostro
territorio. Per coltivare quei terreni fu poi necessario l’invio di vassalli
che, unitamente agli eremiti giunti a costruire chiese e a diffondere la parola
di Dio, quasi sempre si ritrovarono ad utilizzare braccia di servi indigeni,
sopravvissuti in Oppidi e Starze, convertendoli e sottomettendoli col dono
della parola di Dio alle loro dirette dipendenze. E di che cosa servirsi se
non di materiale preesistente della zona, ossia pietre, ferri e legna provenienti
da Ville, Tombe, Are, Strarze, eccetera?! E come chiamarli quei luoghi se
non coi nomi naturali che già gli appartenevano, legandoli ai simboli o ai
culti che li avevano preceduti? Il metodo seguito fu lo stesso per molti secoli,
nel 500 come nel 1000.
Il ducato di Benevento era organizzato come un
regno in quanto fu diviso in distretti, ciascuno dei quali affidato ad un
gastaldo che dipendeva direttamente dal duca.
Il guastaldo era una sorta di governatore, futuro conte
secondo l’uso introdotto successivamente dai Franchi, che aveva dato ai suoi
sculdasci le funzioni amministrative, fiscali e giudiziare delle curtis ricadenti
nel proprio guastaldato. Tante curtis, amministrate da un vassallo (spesso
un ecclesiastico) che le poteva anche vendere a ricchi guerrieri e cittadini
liberi beneventani. E’ pensabile che siano state rispettate più o meno le
suddivisioni dei fondi affidati ai patrizi romani con le Starze. Molti nobili
romani, scrive Paolo Diacono, furono uccisi per avidità; altri, ripartiti
come ospiti perché consegnassero la terza parte dei frutti ai Longobardi,
divennero tributari di quelli che appunto si chiamavano gvass, ossia amministratori
degli ospiti romani.
Le curtis locali delle nostre parti ricadevano
fra le proprietà di un certo Leo, guerriero longobardo, che aveva donato tutti
i suoi beni all’abbazia di Montecassino, tra cui il guastaldato che comprendeva
sette curtis minori tra Benevento e Transmonte (Avellino!?); in verità de
Abellino seu de Transmonte, cioè appartenenti ad Avellino altrimenti (seu)
detto Transmonte (che qualcuno vuole identificare con molto anticipo con Summonte);
comunque in queste pertinenze. I confini non erano ancora ben chiari in quanto
la divisione dei territori era stata fatta da poco, ma quel primo guastaldato
era comunque in territorio del Partenio.
Tutti i territori ivi ricadenti dipendevano appunto
dal guass locale che aveva o stava facendo nascere un Castrum sotto il monte.
Forse anche il territorio dell’attuale Roccabascerana ricadeva in quel guastaldato;
ed era già una delle sette curtis minori di cui si parla.
Alla fine del Regno longobardo di Pavia, caduto
nel 774 sotto il dominio dei Franchi, il ducato di Benevento restò in piedi
in quanto i Franchi si dichiararono anche re dei Longobardi. Lasciando le
cariche più o meno invariate, Arechi II (758-787), duca di Benevento, cambiava
solo il suo titolo in Principe, e quello dei suoi guassalli in conte, indi
dei guastaldati in contee, lasciando le curtis per circoscrizioni.
Una di queste contee fu anche in Valle Caudina,
dov’erano casamenti certi esistenti al momento dell’arrivo del guass che intese
costruire i castelli in questa zona di sotto il monte Partenio, vergine, cioè
non abitato. Del resto le stesse rocce di Rocca sarebbero state affidate ad
un gvass longobardo, il guass Rayno, dipendente amministrativamente da una
contea che non ci è ancora nota.
L’abbazia di San Modesto (come quella di Santa Sofia) di
Benevento, forse già costruita dalla nobildonna Duda Parda per “dare -scrive
Tropeano - decorosa sistemazione alle reliquie del martire Modesto, che papa
Gregorio nel 591 avrebbe fatto trasferire da Roma a Benevento e che il vescovo
Ildebrando il giorno 2 ottobre del 648 o 649 avrebbe solennemente deposto
sotto l’altare maggiore della nuova chiesa al Santo dedicata (Acta Sanctorum,
octobris, I, pp. 325-9);” era uno dei complessi benedettini più antichi creati
da Arechi intorno al 760-780 che, dopo la sua conversione, fu restaurato (a
dire sempre di Tropeano) ed altri ne furono fondati.
Ed è proprio in questi anni che, ai piedi del Partenio, quindi sotto il
monte detto anche Virgineo, nasce il culto a Santa Maria Vergine e Genitrice
di Dio, in una Chiesa sita a valle della montagna (ipoteticamente da noi identificabile
nelle adiacenze del futuro Casale di Capriglia-Embreciera denominato appunto
Santa Maria, ma studi approfonditi potrebbero dimostrare anche il contrario,
atteso che nel Catologus Baronum dei Normanni si parla di una chiesa di San
Vito anche in territorio di Airola). Questa Chiesa, nel conservare sempre
il corpo di San Vitaliano, avrebbe avuto proprietà in tutta la zona, con delle
dipendenze intitolate proprio a Santo Vito - vedi Taverna del Monaco (San
Vito) oggi in territorio di Grottolella o Chiesa di San Vito a Cappella di
Pietrastornina- donate al piccolo eremo, fin su la montagna di Pietrastornina,
dove tutt’oggi esistono i resti di una dipendenza intitolata a Sant’Agliano,
ossia Vitagliano. Il Casale sorto intorno alla Chiesa di Santa Maria esisteva
già prima della nascita dei castrum. Che la chiesa fosse ubicata su un confine
di contea e che fosse nata come dipendenza dell’abbazia beneventana di San
Modesto è ormai cosa certa. Escludiamo che potrebbe trattarsi della Chiesa
di San Modestino di Mercogliano, nata sulla tomba di alcuni soldati romani
che, gridando al finto miracolo, fu scambiata con quella di San Modestino
per un errore di lettura delle lapidi (come successe posteriormente a Mugnano
con Santa Filomena, col corpo di Santa Filomena mai esistito).
Attorno a delle piccole chiese, tanto per essere semplici,
abbiamo detto che giunsero dalle abbazie centrali delle famiglie di vassali
con i servi della gleba per dissodare, coltivare e creare rendite. Ed è quello
che successe anche per i casali del Partenio e della Valle Caudina dove, da
tempo immemore, possedeva fondi anche il monastero romano di Farfa. Comunque
sia, convertiti alla fede cristiana i templi della Valle Caudina, sorsero
intorno ad essi nuovi nuclei abitati di servi della gleba che andarono ad
unirsi alle case già esistenti, se esistenti.
Con l’invasione dei Longobardi, dunque, anche
in territorio di Roccabascerana fu edificato un maestoso Castrum, una fortezza
solo militare, di cui, fra distruzioni e rifacimenti, ancora oggi è possibile
ammirare i resti ricadenti intorno alla Rocca, dove c'è l'antica stradina
denominata via Guardiola, cioè via della Guardia, dell'avamposto militare,
alias la torretta del castello. Attorno ad essa si strinsero nel tempo i contadini
per sfuggire alle incursioni delle bande di briganti e malandrini. Siamo ormai
alla nascita dei primi casali, fra cui la prima fondazione di quello che sarà
chiamato Castello di Roccabascerana.
Più che un Castrum da difesa di proprietà dei
monaci, bisognerebbe però parlare della terra dove ricadeva il Castello, probabilmente
fatto costruire dagli stessi Longobardi che, dopo l’entusiasmo della conversione
al Cristianesimo, rivendicarono l’acquisizione delle terre conquistate dai
loro padri.
Diviso il territorio dai Longobardi, chiese e casali, andarono
a ricadere in ogni curtis propria, come nel caso di Rocca, dei fondi autosufficienti,
abitati, dove si lavorava la terra ma si facevano nascere anche piccole attività
artigianali, con i discendenti di quello stesso patrizio che aveva originato
il fondo, se restarono ancora in loco. Tutti i coloni dipendevano comunque
da un amministratore, che poteva essere o meno un discendente di quel patrizio,
o un sacerdote visto che c’era la chiesa. Due delle sette curtis descritte
nella donazione di Leo, infatti, erano amministrate da un sacerdote. I guerrieri
e le loro donne della curtis erano stati resi anche uomini liberi, mentre
i servi continuavano ad essere obbligati a lavorare per l’abate di Montecassino
per almeno quattro mesi all’anno a titolo gratuito. Un paradiso quasi terrestre,
insomma, completato con la conversione totale dei principi beneventani, i
quali, nei primi anni, non avevano saputo far altro che costruire fortezze
militari, come Rocca, San Martino, Sant'Angelo a Scala, Cervinara, Pietrastornina
o Altacauda, guardandosi in cagnesco l’uno contro l’altro.
Innamoratisi poi, i principi, del monastero femminile
di Santa Sofia, si tennero strette le Sante Terre Beneventane, pur continuando
ad abitare i loro freddi Castelli per far costruire armi, ponti, strade e
muraglioni, ma permettendo alla Chiesa di amministrare i territori assoggettati
avuti in dono. I Longobardi, nel frattempo, esauritosi l’entusiasmo iniziale
dell’assoluzione o della redenzione, non sapendo che fare, dovettero scocciarsi
e cominciarono a vantare qualche diritto in più. Anche perché i tempi cambiavano,
c’erano altri barbari, più barbari di essi, che tagliavano le teste e venivano
dall’Oriente.
Secondo una teoria tutta nostra, la prima chiesetta nella zona del monte
Vergine, fu intitolata a Santa Maria Vergine e Genitrice di Dio. Si tratterebbe
di un piccolissimo, minuto, sconosciuto, ma famoso eremo, che avrebbe poi
dato origine al culto alla madonna del monte Vergine, fatto nascere su un
feudo divenuto di proprietà del monastero di San Modesto di Benevento. Quando
infatti si erano cominciati a conoscere e suddividere i latifondi, a Benevento
si era pensato bene di vendere, permutare, cambiare, unire e via discorrendo,
terreni, e famiglie di vassalli (casamenti abitati dalle tre o quattro fuochi
di contadini presenti) con altre Chiese, orfanatrofi o privati cittadini liberi
delle varie province sannitiche e con abbazie lontanissime, come quella di
Montecassino.
E’ a quei tempi che l’eremo di Santa Maria, proprietà
di Montecassino, fu permutato con San Modesto di Benevento, probabilmente
con l’assenso dei coloni in quanto, per istrumento, l’unico diritto che avevano
i coloni era quello di poter decidere di essere ceduti o meno dall’abbazia.
E Santa Maria, non più eremo, sarebbe diventata dipendenza di San Modesto,
con il suo monaco preposto. Piccoli appezzamenti, quelle curtis, dove si sudava
per vivere in cambio di un tozzo di pane e sognando la libertà.
Con il sopraggiungere dei Longobardi la classe
dei
patrizi romani fu assorbita e assoggettata. I patrizi restavano uomini
liberi, anche perché Alboino era alleato dell’Impero Bizantino nel quale i
territori beneventani ricadevano, amministrando quindi i territori e mantenendo
le loro ville.
Se un nascente guastaldato di Rayno ci fu, allora,
non ebbe origine dai casali della zona, ma ebbe sede in un Castello che si
doveva costruire e che quindi, costruitolo sulle pendici del monte, originariamente
detto Castrum GuassRayno. Il guass locale decideva di abbandonare il contado
per fondare un Castrum che fu detto della Rocca (ma che comprendeva tutte
le altre rocce della zona divise in curtis) in quanto, il suo duca di Benevento,
era entrato in conflitto con i Bizantini, specie dopo l’assassinio del duca
Sicardo nell’839. Ne seguirono quindi lotte fraticide, tra duca e duca, tra
guass e guass, tra guass e patrizi locali patteggianti per i Bizantini finché
non si decise di fondare questo castello dal quale si potevano meglio controllare
tutte le sette corti (più o meno gli attuali casali di Tuoro, Cassano, Squillani,
Zolli, Tufara...), in attesa di capire cosa succedesse a Benevento nella lotta
di successione verificatasi alla morte di Sicardo, quando il fratello Siconolfo
si scontrò con Radelchi, tesoriere di Sicardo sostenuto da una parte della
nobiltà beneventana. Nella guerra dell’uno contro l’altro furono chiamati
dei rinforzi dalla Sicilia, delle soldatesche arabe, ossia i Saraceni.
Dopo un astio durato anni, nell’849, fu pace fatta
tra i duchi longobardi che si divisero i territori assoggettati. Dodici anni
di guerra terminati ufficialmente nell’851, con la divisione fra il principato
di Salerno e quello di Benevento, con a linea di confine proprio la cima del
Partenio, per serram montis virgini, dove questo guastaldato confinava con
l’altro di Cimitile ricadente nel Principato di Salerno, prima che anche Capua
insorgesse per rendersi indipendente.
In questi anni si staccano da Benevento alcuni
guastaldati tra cui quello di Furcule, al quale appartiene per certo San Martino
in Furcule (ovvero San Martino Valle Caudina), Tocco (da Tocco Caudio fino
a Ponte Ursi dopo la Tufara alle porte di Benevento) e alcune signorie autonome.
Il nostro guass, cioè il neo vassallo di tutte
le rocce del precedente gvass Rayno, se non rientrò in Tocco, fu certamente
uno degli autonomi vassalli beneventani. Egli innalzò un Castrum per difendersi
da eventuali invasioni dei vassalli di Furcule, Tocco, eccetera.
Il Castello di Cervinara, per esempio, prima dell’837
era dipendente dall’abate di San Vincenzo al Volturno, ma la proprietà della
fortezza militare - lo pensa lo studioso Barionovi - dovette essere dei Bizantini.
Di certo appartenne ai principi longobardi di Benevento e seguì la sorte di
questa città finché restarono i Longobardi nella terra beneventana della Chiesa.
Del resto, i castelli, erano nati a destra e a manca con la comparsa dei Saraceni
nella zona, chiamati dai Napoletani contro Sicardo, per proteggere le case
dei contadini che tendevano ad avvicinarsi alla cinta del Castello per sentirsi
protetti. Scontri violenti fra gli invasori, calamità, distruzioni: sono sempre
duecento anni in cui nessuno sa cosa successe.
In questi anni, il piccolo guastaldato delle Rocce
di Guasserana, nato proprio lungo al direttrice che da San Martino porta a
Mercogliano, diventava potente, con il suo guass ivi trasferitosi, che aveva
giurisdizione su tutte le corti minori, i casali, facendo qui nascere la confusione
storica relativa alla prima chiesetta di Sant'Angelo che alcuni vogliono a
Rocca, altri a Cervinara, altri ancora a Sant'Angelo a Scala, taluni a Ceppaloni.
La Chiesa di Sant'Angelo è la prima chiesa di Rocca, costruita ai piedi
del borgo, dove tutt'ora è sita, seppure trasformata nel corso degli anni.
Il primo documento storico sulla chiesa è "dell'anno 971 e riguarda una permuta
dei beni dell'arcivescovo Landolfo di Benevento con l'ospedale, in cambio
della Chiesa di Sant'Angelo de loco Quascirana, tenuta dal chierico Roffredo
in benefizio" (nella ristrutturata chiesa di Sant'Angelo, nel 1700, sono stati
costruiti due affreschi con le effigi di San Domenico e Santa Caterina).
A Castel Quascirana erano presenti famiglie longobarde
che, probabilmente, come scrive Matarazzo per Summonte, “costituivano la quasi
totalità dei proprietari in una popolazione formata prevalentemente di contadini,
pochi artigiani e qualche sacerdote”. Diedero quindi ampio spazio all’agricoltura,
incrementandola e facendola progredire. “In tutti i contratti di affitto di
terreni - continua Matarazzo -, che erano quasi sempre incolti - terra vacua
- l’affittuario si obbliga a renderli produttivi, trasformando i greccoli
in castagni da frutto con un buon innesto - ramare et calvare et ibidem palumbare
- (da: r. n. 401, Codice Diplomatico Verginiano di don Placido Tropeano)...
l’agricoltura era notevolmente progredita”. Oltre la stessa organizzazione
politica.
Con il nuovo sistema introdotto dai Franchi, ai
quali si erano assoggettati i principi di Benevento, il guass del nostro Castrum
perse l’autonomia e fu assoggettato ad un conte, probabilmente di Montesarchio
o di un altro castello principale della Valle Caudina.
Morto l’ultimo principe longobardo di Benevento,
Landolfo VI, dopo il 1076, già cominciava ad affluire dalle nostre parti l’onda
normanna, che portò alla pace di Ceprano il 1080. I figli di Tancredi d’Hauteville,
tra cui Ruggiero e Roberto il Guiscardo che avevano battuto, sul Fortore,
l’esercito di papa Leone IX, facendosi riconoscere l’investitura feudale su
tutte le terre conquistate con il giuramento di Melfi del 1059, si diedero
subito un gran da fare. Roberto, tranne Benevento, aveva il predominio su
tutto il territorio conquistato.
"Quando gli stati della Longobardia meridionale", scrive Luigi Barionovi
in "I feudi caudini" su Samnium, "volgevano alla estrema rovina sotto l'urto
dei Normanni, uno degli ultimi principi longobardi, Pandolfo IV di Benevento,
figlio ed associato di Landolfo VI morì nella Valle Caudina a Montesarchio
nel 1073: Pandolfus princeps Monti Sarcli occiditur mense februario, o come
dice un'altra cronaca: occisus est autem a Normannis ad Montem Sarclum".
I Normanni compaiono in Valle Caudina già dopo il 1075.
"Nello stesso periodo del secolo XI", scrive sempre Barionovi, "un comes normanno
aveva nella Valle Caudina possedimenti così vasti da poterne trarre larghe
donazioni per un monastero", che riguardano tutto il territorio di Cervinara
con sei chiese e una ventina di casali.
Dopo aver preso Bari (1071) ed altre Terre, i Normanni ebbero il riconoscimento
ufficiale del Regno, nel giorno di Natale del 1130, con l’incoronazione di
Ruggiero d’Altavilla. Essi organizzarono i territori conquistati con la forma
del feudalesimo, basato sulla indivisibilità dei feudi e sulla loro trasmissibilità
solo al primogenito, con il divieto di dividere le proprietà: giusto l’inverso
del sistema longobardo. Aboliti i vecchi contadi dunque, i territori conquistati,
come risulta dal Catalogo dei Baroni, compilato fra il 1142 ed il 1156, furono
divisi in contee più grandi, come Conza, Apice, Avellino...
Giunti i Normanni, la Valle Caudina e tutti i
castelli ex Oppidum sanniti, sopravvissuti ai Saraceni, in essa racchiusi
furono da Re Ruggieri (o Ruggero II) dati in dote alla sorella Matilde de
Hoteville, che sposò Rainulfo Butterico conte di Avellino. Ruggiero era il
primo re normanno della Sicilia, figlio di Ruggeri I principe normanno, il
quale, fatto prigioniero papa Innocenzo II, da lui si fece cedere il ducato
di Puglia e il principato di Capua. Dopo il 1108 si parla nuovamente del Castrum
inteso come fortezza, e si sa qualcosa in più anche sul Castellum di Roccabascerana:
un agglomerato abitativo (borgo fortificato) comprendente case coloniche,
casalia hominum, ai tempi, appunto, della dominazione normanna. Successe poi
che Castello e borgo dovettero essere distrutti dagli invasori, in quanto
anche la terra di Roccabascerana fu assorbita, politicamente, dal Castello
di Apice (o Montesarchio o Tocco) che il conte Normanno aveva scelto come
sede politico-amministrativa dell’intera Contea. Castello che dovette accogliere
tutti i casalini superstiti veri e propri di chissà quale battaglia se è vero
che nel 1127 si parla di ex Castello, zona in cui la Chiesa, approfittando
dei litigi comitali, incrementò l’invio di monaci, per nuove e vecchie fondazioni
ecclesiastiche, con al seguito intere famiglie di casalini da utilizzare per
dissodare le terre. Roccabascerana dunque, guardata da militi, ricadeva sotto
il comando di un conte. Null’altro apprendiamo dal catalogo dei baroni Normanni
su questo periodo.
Il Di Meo riferisce che nel 1132 Matilde de Hauteville
venne in rottura con Rainulfo, rifugiandosi dal fratello a Salerno, col quale
si lagnò e protestò in quanto non voleva più unirsi al marito, dal quale rivoleva
indietro la dote. La già nota contesa fra Re Ruggieri ed il conte di Avellino
a questo punto si inasprì e il conte, con un esercito di 3.000 cavalieri e
40.000 fanti, si recò nei suoi Castelli della Hauteville in Valle Caudina,
dove aspettò l’assalto del cognato. Guerreggiò per ben tre anni, fino al 1135,
quando fu sconfitto e tutte le terre e gli oppida della Valle furono posti
a sacco e fuoco, eccetto Montesarchio ed Arpaia, unici due luoghi fortificati
esistenti per certo.
Nel 1168 la maggior parte dei feudi caudini entrano a far
parte del pincipato di Capua e della camestabulia capuana. Con il sopraggiungere
degli Svevi, con Federico II sul trono del Regno di Sicilia, non volendosi
arrendere, la Valle Caudina fu nuovamente distrutta e messa a fuoco al passaggio
delle truppe del re, che ridussero in briciole il borgo e il Castello di Cervinara,
già ricostruito per la seconda volta da Rainulfo II. Subito dopo il re ordinò,
siamo nel 1240, che il Castello di Montesarchio fosse elevato a dignità imperiale,
come nel caso di Pietrastornina, Avellino ed altri, e quindi ad avere giurisdizione
sull’ex comestabulia del principato di Capua, ora sotto-provincia foggiana
della Valle Caudina, per essere stati, gli altri Castelli rasi completamente
al suolo, ma anche per darsi un’immagine, un tono, adesso che c’era un potere
diverso, c’era uno stato nuovo: il Regno di Sicilia.
Nel 1240 per esempio, Roccabascerana, unitamente
a San Martino, era tenuta alla riparazione, alla guardia e alla custodia del
Castello imperiale di Montesarchio, ove c’era un fidato giureconsulto dell’imperatore,
ivi insediatosi per l’amministrazione dei feudi e il controllo degli stessi
signori, oramai tutti fedeli di Casa sveva. Nello statuto per la riparazione
dei castelli del tempo di Federico II di Svevia è detto che alla riparazione
dovevano contribuire anche gli "homines Rocce de Guassarano", oltre quelli
di San Martino, Cervinara, Apollosa, Arienzo (in Terra di Lavoro) e agli stessi
di Montis Sarcli. Nel territorio di Rocca però, anche se non c’era più una
sede politica nel Castello, cominciavano a nascere i primi palazzi, forse
di proprietà ecclesiastica, fermo restanti i beni dei vari sopraggiunti monasteri,
come quello di Montevergine, quantizzabile in decine di casalia hominun, costituiti
dalle case e dai naturali di quell’ex Castello addetti a coltivare la terra
della fondazione ecclesiastica di Montevergine. Si tratta di case sparse,
di casate di coloni, di monasteri che nella zona già possedevano anche le
chiese. Santa Sofia, per esempio, aveva numerosi possedimenti in Valle Caudina
che ricadevano sotto la giurisdizione della Chiesa di Sant’Adiutore “apud
Montem Virginem” già dal 1120. Molti beni di Santa Sofia erano passati - evidentemente
- da Benevento ad Airola, Montevergine, Capua...
Durante la lotta tra Re Manfredi di Svevia ed
il papa, l’esercito pontificio, comandato dal cardinale Ubaldini, si era accampato
in alcuni territori lungo la via Appia, ritrovando ristoro fra le varie dipendenze
della Chiesa. Nelle succesive lotte con Re Carlo d’Angiò, vi si accampò poi
il regio esecito angioino, poco prima di uccidere Manfredi nel 1266.
Non sappiamo ove fosse nato il primo nucleo abitato
di Quascirana; è evidente però l’ubicazione della fortificazione dal momento
in cui si parla di un feudo delle Rocce Guasserane, cioè delle rocce che anticamente
furono assoggettate del guass Rayno.
Più interessante sarebbe stato conoscere il pagus di Rayno
che possiamo immaginare nei pressi di Furmo di Pietrastornina, dove sbuca
un’altra strada proveniente da Pascone di Pietrastornina chiamata proprio
via Raino. Torniamo però al nascente feudo di Roccabascerana che comprese
tutte le altre rocce intornno alle quali erano nati dei Casali, delle piccole
curtis cioè.
Cassano Caudino trarrebbe origine da uno dei templi
eretti dopo la vittoria dei Romani sui Sanniti, cioè da Casa di Iano in zona
di Caudium; più accreditabile però l’ipotesi di una villa romana di un patrizio
di nome Cassiano in Caudium, cioè della famiglia dei Cassi o Cassio di Caudium.
Squillani è apparso fino ad oggi di origini più
“moderne”, medioevali, come Casale della famiglia Squillaci, fondato appunto
dai vassalli degli Squillaci. In realtà, come detto, i ritrovamenti testimoniano
la sua antichità e lo stesso Casale sarebbe proprio l'altra curtis. Idem per
La Tufara Valle, che prendendo nome proprio dalla presenza di una cava di
Tufo intorno alla quale sarebbe sorto un abitato; e lo stesso discorso vale
per Zolli, che trarrebbe origine dalla casata degli Zollo, ma, in realtà,
è giusto l'inverso. Sono cioè i Casali, le Curtis, a dare nome alle famiglie.
Una medesima ipotesi si deve fare per Tuoro, che, sicuramente, non ha origine
dal greco, altrimenti si sarebbe detto Moscos.
Scrive Iannacchini che “la
valle solcata dalla Volana,
che scende dalle giogaie del Partenio presso Pietrastornina,
nonché dall’Isclero o Schito presso Cervinara, entrambi affluenti del Sabato,
fu anticamente abitata dai Caudini, del sangue dei Sabelli”. In epoca romana
e preromana, i Caudini erano tutti i popoli del Distretto di Caudium, come
asserisce anche Francesco Cillo, che comprendeva centri tra il Taburno ed
il Partenio, da Saticula di Sant’Agata dei Goti, fino all’Oppidum Quadrellarum
di Quadrelle e alla Città di Avella nel Baianese, atteso che quei colli portano
tutti il nome di Caudio.
Ai Sanniti fa pensare il territorio di Roccabascerana,
diviso fra i villaggi, come era nel costume dell’antico popolo abitare dei
vicatim, come indicato da Tito Livio; ma fu però solo dopo la vittoria successiva
alla dolorosa sconfitta delle Forche Caudine, da parte dei Romani, che videro
la luce Colonie agricole, Ville e Oppidi, premesse alla nascita dei successivi
centri ed è quindi, quasi certo, che l’attuale Roccabascerana centro sia nata
con la calata dei Longobardi.
Il primo documento storico che parla di Roccabascerana
è dell’anno 971 e riguarda una permuta dei beni dell’arcivescovo Landolfo
di Benevento con l’Ospedale, in cambio della Chiesa di Sant’Angelo de loco
Quascirana, tenuta dal chierico Roffredo in benefizio.
E’ pensabile che la Ecclesiam, di cui si parla,
fosse stata eretta dagli stessi Longobardi, su terreni della chiesa, mentre
essi si impossessavano della roccia per edificarvi un castello e, da qui,
sarebbe nato anche il nome dato al nuovo borgo, abitato dai loro coloni mandati
a dissodare i terreni di Rocca Quascirana. Di Rocca Guasserana si parla infatti
in un documento successivo del 22 febbraio 1275, in riferimento alle rendite
che gli abitanti dovevano pagare al monastero di Montevergine per l’usufrutto
dei beni che l’abate possedeva in quella terra.
La chiesa di San Giorgio del 1300. La primitiva costruzione
era di semplice fattura, una semplice cappella baronale. L'interno era decorato
con legno di castagno lavorato a mano ad intarsio. Possedeva un battistero
di marmo pregiato. Sull'altare c'era un dipinto di Maria Santissima del Carmelo.
Il suo archivio conservava tutta la storia di Roccabascerana, con documenti
che interessavano il santuario di Montevergine. Nell'anno 1929 la chiesa fu
distrutta da un incendio e andò perduto anche tutto l'archivio. La nuova chiesa,
così come oggi appare, è stata costruita nell'anno 1936, a poca distanza dalla
precedente ed in stile gotico.
Al tempo degli Svevi, il feudo appartenne ai Mascambrino, discendenti
di Riccarco, secondogenito di Girolamo II principe di Capua, di stirpe normanna,
che possedeva la Rocca Vascarana e Polcarino. Altri parlano di un Filangieri
che, parteggiando però per re Manfredi, all’arrivo degli Angioini (o Giovanni
Mascambrino?), fu spogliato dei beni da Carlo I.
Nel 1269 il paese, detto Rocca Guascirana nei documenti, assunse una certa
importanza, pagando 36 tarì per mantenere i militi del castello al servizio
della contea.
Nel 1400 ritroviamo il feudo di proprietà della
famiglia di Marino della Leonessa, figlio di Guglielmo, eppoi di Giovanni
nel 1446, per passare poi ai Della Marra. Sappiamo però anche che la rocca,
già nel 1410, era tenuta da Nicola Pizulo.
Il feudo, in possesso di Giacomo Antonio Della
Marra, fu dal re Ferrante d’Aragona, nel 1467, venduto insieme a Montoniorio
e Gualdo a Sperone De Gennaro, fino a passare nei poteri di Antonello Dentice
che, con Giambattista Brancaccio, cambiò il feudo con quello di Ceglie nel
1484, per rivenderlo infine a Federico Spiniello nel 1486. A costui seguirono
Troiano (1498), Federico (1529) e, nel 1534, la zia Lucrezia Spiniello che,
nel 1560, vendè Rocca a Francesco D’Aquino.
La popolazione crebbe al punto che, mentre nel 1532 si contavano
circa 400 abitanti, arrivò intorno al 1590 a 900 anime. La peste del 1656
falcidiò mezza comunità, al punto che, nel 1669, si contavano appena 48 famiglie.
E’ pensabile però che in queste cifre non siano compresi gli abitanti dei
casali di Cassano, Squillani, Tufara, Tuoro e Zolli probabilmente appartenuti,
in quel periodo, ad altri feudi dei castelli vicini.
Nel 1606, a Francesco d’Aquino, era succeduto
il nipote Francesco II e, nel 1610, Ottavio. Seguirono Tommaso nel 1613, Giuseppe
nel 1635 e, nel 1669, il nipote Carlo Capocelatro, figlio della sorella Beatrice
d’Aquino, che nel 1712 vendè il feudo per 22.500 ducati a Fabio Della Leonessa.
Nel 1730 gli successe il figlio Giuseppe e, nel 1772, Fabio che morì nel 1779.
Ultimo feudatario di Roccabascerana, prima dell’abolizione
della feudalità, fra un terremoto vero e un sisma finto (spesso la compravendita
dei feudi era solo un “gioco” di titoli) fu un Giuseppe Della Leonessa, principe
di Sepino e duca di San Martino Valle Caudina.
Con l’abolizione della feudalità, da parte dei
nuovi conquistatori francesi, Rocca fece parte del Principato Ultra, della
provincia cioè di Montefusco. Nl 1799 il popolo aveva partecipato ai moti
rivoluzionari, ma col ritorno borbonico si adeguò. I Borboni edificarono in
Rocca una sede della guarnigione e un carcere mandamentale, fino al ritorno
francese del 1800. Spostato il capoluogo di provincia ad Avellino nel 1801,
il paese restò in Irpinia anche dopo il 1860, quando buona parte della Valle
Caudina si staccava, unendosi ad altri paesi del rinato Sannio e Benevento
diveniva provincia a se.
C’è da ricordare che uno dei figli più illustri
di Roccabascerana fu il rivoluzionario Matteo Imbriani, patriota dei moti
antiborbonici del 1820-21 per i quali si meritò la condanna all’esilio. Illustre
anche il Paolo Emilio Imbriani nato in Napoli, dove Matteo si era trasferito,
sposo adorato di Carlotta Poerio, protagonista anch’egli, insieme a De Sanctis
e a Poerio, del movimento risorgimentale che portò all’Unità d’Italia, non
senza contributi di sangue pagati anche dai paesi della Valle Caudina e del
Partenio che, in nome della Patria, già con la Repubblica Partenopea del 1799,
avevano eretto nelle loro piazze i tigli della libertà. Ed è proprio il tiglio
di Roccabascerana a rinverdire dopo 200 anni, grazie ad un intervento fitosanitario
voluto dall’amministrazione comunale di Natalino Renna, su interessamento
del vice sindaco Ottavio Viscione.
Intorno al 1860 Roccabascerana venne sconvolta
da una vicenda di passione e di sangue che coinvolse una delle sue più importanti
famiglie. Il notaio Gennaro Principe aveva ospitato, seppure malvolentieri,
il noto brigante Costanzo Majo, suo lontano parente. L’inquieta ed avvenente
moglie, Matilde Rossi, si invaghì del bandito e, dopo aver collaborato con
il Majo a trucidare il consorte, prese con lui la strada dei monti.
Erano trascorsi due mesi, sia per i mutamenti
politici che per l’acquisita consapevolezza di non avere un futuro, quando
la donna, presi accordi con la famiglia, una sera, dopo aver spinto l’amante
a mangiare e a bere più del dovuto, e dopo averlo stordito e fatto cader in
un sonno profondo con le sue lascive carezze, prima gli sparò e poi gli staccò
la testa con un’ascia.
Con la testa, racchiusa in un sacco, donna Matilde
discese dai monti di Avella e si presentò alle autorità di polizia di Avellino,
che la fecero arrestare come complice del Majo per l’assassinio del marito
e tradurre nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Dalla sua cella, Matilde
Rossi, fece pervenire a Garibaldi, tramite il suo avvocato, allorché il dittatore
in nome del re Vittorio Emanuele II entrò in Napoli, un memoriale in cui giurava
di essere stata costretta con le minacce a seguire il brigante ma che aveva
vendicato l’onore, appena possibile, dimostrando nel contempo l’amore per
la Patria comune con l’uccisione del brigante filoborbonico; e l’eroe dei
Due Mondi non solo la tirò fuori e la fece ringraziare in nome “della moralità
pubblica”, ma volle riceverla nel suo vagone alla stazione di Caserta, dove
la donna, appena liberata dal carcere, si era portata per ringraziare il dittatore
del provvedimento preso in suo favore.
Che cosa abbiano fatto i Consiglieri provinciali
del mandamento di Mercogliano che si sono succeduti dal 1861 al 1901 per la
gente dei paesi limitrofi è difficile dirlo. Sappiamo però che anche Roccabascerana
era tenuto in considerazione dal cavalier Paolo De Cristofaro (1861-80), dal
sacerdote Alfonso De Cristofaro (1881-87), dal cavalier Nicola Campobasso
(1887-1901). In particolare, però, Roccabascerana, ricadendo nel mandamento
di Cervinara, in quegli anni ha eletto in successione Giovanni Finelli (1861-62),
Alessandro Campanile Cocozza (1862-67), il cavaliere Francesco Del Balzo (1867-71)
e il barone Girolamo Del Balzo (1871-1901).
Di Roccabascerana conosciamo gli esercenti dell’arte
salutare che, nel 1880, risultano essere il dottor Antonio Maffei di Giuseppe
e il dottor Donato Maffei di Giuseppe che facevano i medici chirurghi condottati
e il dottor Luigi Maffeo di Antonio, anch’egli medico.
La signora Maria Toderico di Pasquale esercitava
invece la professione di levatrice, titolo che aveva conseguito il 15 dicembre
del 1860 presso l’università di Napoli. Raffaele Imbriani e Giuseppe Maffei
di Alessandro erano i due farmacisti anch’essi laureatisi presso l’università
di Napoli.
A quei tempi, diciamo per esempio nel 1889, Roccabascerana, con i villaggi
di Tuoro, Cassano e Squillani contava 3.258 abitanti. Il paese era abbastanza
grande e commerciava in vini rossi e nocciole lungo la via provinciale Irpina
e la Partenio-Guardiola che da Mercogliano menava a San Martino. Già dal 1884-85
abbiamo notizia di noti “industriali”. Francesco Barbati fu Aniello, Luigi
Ciccone fu Domenico, Francesco e Giovanni Imbriani fu Michele, Fedele Imbriani
di Angelantonio, Pietro Izzo fu Saverio, Giovanni Iavarone fu Pasquale, Antonio
Maffei fu Giuseppe, Giovanni Principe fu Angelo, Giovanni Principe fu Francesco,
Biagio Principe fu Giorgio, Alfonso Rossi fu Emmanuele, Pietro Rossi fu Antonio.
Notizie più approfondite ne abbiamo però solo sugli ultimi anni di fine
secolo, a partire dal 1889, quando sindaco del paese era Michele Imbriani,
coadiuvato da Nicola Maffei nella qualità di segretario e da Fedele Imbriani
che faceva l’esattore. I due assessori erano invece Francesco Barbati e Marcello
Rossi.
Il parroco si chiamava don Angelo Raffaele Principe,
che curava le anime della parrocchia guardato a vista da Giovanni Imbriani,
presidente della Congrega di Carità. Nutrita la famiglia clericale con ben
9 chierici: Agostino Cicotti, Isidoro Limata, Antonio Cafasso, Antonio Izzo,
Federico Principe, Crescenzo Mazzone, Ignazio Mazzone, Paolo Pipicelli e Giuseppe
Iodama. Di certo si sa anche che il conciliatore era Donato Maffei con vice
Antonio Maffei.
Molti dunque gli abitanti dell’epoca che mandavano
a scuola un nutrito numero di alunni, 172, dislocati nelle 7 scuole elementari
sotto la guida degli insegnanti Pasquale Limata, Nicola Rossi, Gennaro Pincipe,
Raffaella Carpentieri, Enrichetta Lombardi, Filomena Rossi e della maestrina
Vittoria Maffei. Nel mentre i medici chirurghi erano cambiati. Ritroviamo
infatti i dottori Donato e Antonio Maffei a fare i condottati, mentre gli
altri tre professionisti laureati erano l’avvocato Michele Imbriani e i farmacisti
Giuseppe Maffei e Raffaele Imbriani. Angelo Gengaro era il barbiere del paese;
un buon caffè lo si poteva trovare da Maddalena Santoro, Angelo Gargano e
Bonino Chirico. Il capo-mastro muratore del paese era Diodato Principe; il
falegname Sabino Maffei. Nella classe artigiana locale si distinguevano anche
i poveri calzolai Salvatore Pirone, Leopoldo Viscione, Beniamino Santoro,
Aniello Limata ed Eugenio Iannariello.
Anche se quasi ogni famiglia in paese allevava
il maiale o degli agnelli, vi erano ben quattro macellai dislocati nei vari
centri dei villaggi: Benedetto Viscione, Carmela Viscione, Agostino Parrella
e Francesco Covino. Ai mugnai Giosué Miranda e Pietro Lizza, dobbiamo aggiungere
i nomi dei panettieri Gaetano Siani e Giuseppe Affinito.
Non abbiamo droghieri, in compenso riscontriamo
diversi mediatori e sensali (Carmine Piantedosi, Raffaele Viscione, Crescenzo
Parrella e Franco Mercurio), un discreto numero di sarti (Alessio Piantedosi,
Emmanuele Mazzone, Anna Viscione e Carmine Piantedosi) e, cosa rara, un tabaccaio
per comunità: Giuseppe Limata, Pietro Antonelli, Carmine Fantasia e Gennaro
Covino.
Una “stranezza”? Non riscontriamo né maniscalchi,
né fabbri, come nel caso di Pietrastornina. Non ci resta che ricordare il
nome del titolare della trattoria del centro, Cosmo Barbati.
L’albero genealogico degli Imbriani iniziò a
Roccabascerana per continuare con il ramo di San Martino Valle Caudina
e poi Napoli e poi Pomigliano. Ne riportiamo solo il ramo di Roccabascerana.
Coppola, nella sua ricerca su “La famiglia Imbriani”
afferma che “alle radici dell’albero sta un Giovanni Imbriani vissuto tra
gli ultimi decenni del 1500 e i primi del 1600. Di lui non conosciamo altro,
se non che dev’essere considerato il capostipite, da cui procedono ininterrottamente
tutti gli altri Imbriani di questa famiglia. Dovette essere un piccolo proprietario
terrriero o anche un grosso, per quei tempi, affittuario di Roccabascerana,
inteso alla cura del suo fondo, che formò il primo nucleo del patrimonio”.
L’albero genealogico inizia con Giovanni Imbriani, che sposa Porzia Minucci
di Pietrastornina; di poi viene il figlio Ottavio, vissuto dal 1613 al 1704.
Poi segue il notaio Giovanni Imbriani, che sposa Camilla Scalzo, ed abita
nel luogo detto Lo Puzzo, al centro del paese. Egli genera sei figli, di cui
cinque maschi, Francesco, Ottavio, Aniello, Cesare, Andrea e una femmina,
Porzia.
Da Ottavio deriva la seconda generazione degli
Imbriani con i due figli Nicola e Andrea. Per la terza generazione c’è Matteo
Imbriano con i due figli Giuseppe e Francesco. Nella quarta generazione ci
sono il primogenito Giuseppe e il fratello Francesco. Nella quinta generazione
ci sono Matteo e Anna, figli di Giuseppe. Nella sesta generazione il capofuoco
è Matteo Imbriani, che sposa Caterina di Falco di Pomigliano, da cui nascono
due figli Rosa e Paolo Emilio. Nella settima generazione il ramo principale
non è più rocchese ma si sposta a San Martino Valle Caudina con il capofuoco
Paolo Emilio Imbriani.
Fu abbastanza nutrita la schiera di repubblicani
a Roccabascerana. Porta la data del 12 dicembre 1869 un rapporto dei Carabinieri
inviato al prefetto di Avellino, dalle cui schedature si ricavano alcune notizie.
Il trentacinquenne Giovanni Imbriani, per esempio, viene indicato come possidente
e notaio, compresi i “connotati: statura 1,70; capelli e ciglia biondi scuri;
fronte giusta; occhi celesti; naso regolare; bocca media; viso tondo; barba
bionda; nessun segno particoalre. Partito politico: riscaldatissimo pel partito
repubblicano. Cenni biografici: in quanto alla condotta politica, e nel 1860
e nel 1866 seguì Garibaldi. In quanto alla morale, nulla si potrebbe dire,
se non che vuole farsi temere dai suoi compaesani, come di fatto lo temono
perché capace alla vendetta. Molta capacità tiene nella sua professione, in
quanto all’influenza l’ha mediocre”.
Michele Imbriani, invece, ancora ventiduenne,
era sì possidente, ma studente in legge. Questi i “connotati personali: statura
1,68; capelli, ciglia e barba castagna; occhi idem; naso piccolo; bocca regolare;
viso ovale; nessuna marca particolare. Partito politico: attaccatissimo al
partito repubblicano. Cenni biografici: in quanto riflette la condotta politica,e
nel 1860 e nel 1866 seguì Garibaldi. Riguardando la morale, nulla si potrebbe
osservare se non che è temuto dai suoi compaesani, perché capace alla vendetta.
E’ molto istruito qual studente, ma non gode tanta influenza”. Repubblicano
viene definito invece Achille Principe, 33 anni, possidente. Alto 1,76, capelli,
ciglia e barba castani, occhi turchini, naso giusto e bocca regolare, era
riconoscibile per il viso lungo, la frone spaziosa, e l’occhio destro “semistorto”
quale segno particolare. Per i Carabinieri, Achille Principe, “in quanto alla
condotta politica il medesimo, come si è detto, tende al partito repubblicano.
La morale non è ritenuta tanto buona, perché essendo Sindaco di quel Comune
fu sospeso di tal carica per una contravvenzione essendogli stato rinvenuto
del tabacco di contrabbando nella propria abitazione. Inoltre per altri motivi
di profitto fatti come si dice nella sua amministrazione. Poca capacità tiene,
nonché mediocre influenza”.
In Irpinia sorsero molte sette carbonare. Roccabascerana,
insieme a Arpaise e Terranova Fossaceca, faceva parte della setta denominata
“I seguaci di Jacopo Ortis” (i cui affiliati ammontavano al numero di 300).
“I seguaci di Jacopo Ortis” presero parte alle rivolte del 1820 ad Avellino,
Arpaia, Arienzo, tentando anche d’invadere Benevento. A questa setta appartenevano
anche i due preti, don Giovanni D’Alessandro e Don Innocenzo Polcari. Il primo,
maestro settario di Roccabascerana, fu sospeso dal celebrare messa e dalla
confessione; il secondo, 42 anni, sacerdote a Ceppaloni, aveva partecipato
il 9 luglio 1820 a Napoli nella sfilata dell’Armata Costituzionale, su ordine
del re, fu destituito dall’insegnamento.
Croce diceva che il titolo di magnifico “si dava, nel Regno, ai massari
o industriali di campagna”. Uno di questi era Pasquale Russo, vissuto nel
1700. Aveva sposato Carmela Principe, da cui ottenne cinque figli: Federico,
Agostino, Carmine, Maddalena e Maria. La famiglia Russo abitava ai Principi,
nel casale Cassano di Roccabascerana, in una casa di sei vani. Nel Catasto
Onciario del 1746, Pasquale Russo era classificato come il contribuente più
facoltoso. Aveva il seguente patrimonio: 50 tomoli di terra, 145 capi di bestiame
(65 bovi, 23 giovenchi, 30 somari, 27 ovini) 19 mutui per un capitale di 834
ducati, con un reddito complessivo netto di 331 ducati all’anno. Il Russo
era tassato per 736 once. I due figli Federico e Agostino, industriali, pagavano
il tributo di 14 once ciascuno. Altri due figli, destinati alla chiesa e agli
studi, erano esenti dal pagare le tasse. Il figlio Carmine con gli studi scelse
l’esercizio dell’attività notarile. Pasquale Russo aveva un fratello maggiore
di nome Nicola, che era massaro ma meno facoltoso e abitava ai Bottilli nello
stesso casale di Cassano.
Padre Vittorio Genovesi, sacerdote gesuita, nacque
a Roccabascerana il 23 aprile 1887. All’età di 15 anni entrò a far parte della
Compagnia di Gesù. Nell’ambito ecclesiale ebbe molti incarichi importanti.
Genovesi divenne innografo della Sacra Congregazione dei Riti. Nominato primo
consultore e assegnato alla sezione delle cause di Beatificazione e Canonizzazione,
fu consultore della Sacra Congregazione del Concilio. La sua fama resta legata
ai componimenti poetici scritti in lingua latina. Partecipò ai concorsi di
poesia latina all'Accademia olandese di Amsterdam, ottenendo tre volte il
premio della medaglia d'oro e otto volte la "Magna laus". Con medaglia d'oro
i tre componimenti: Hyle (1936), Taedium vitae (1934), Patrius amor (1948).
Con "Magna laus" i carmi: Roma caput mundi (1935), Satanas (1943), Communia
vitae (1938), Vere novo (1938), Animi certamen (1939), Verbum (1947), Nuntiorum
publicorum glutinator (1948), Talitha (1955), Carmina fidei (1942), Carmina
patriae (1942), Poèmata (1946), Musa latina (1948), Lyra sacra (1952).
Altre opere di carattere religioso sono "la vita
sovrannaturale nei suoi principi e nelle sue manifestazioni", "Il mistero
del Verbo incarnato", "Tra maestro e discepolo", "La verità della fede nella
Bibbia", "Il primato del Papa e la venuta di San Pietro a Roma", "Alla chiesa
credo e ai protestanti no".
Padre Genovesi ottenne molti riconoscimenti, divenendo
socio dell'Arcadia nel 1945. Fu membro onorario dell'Istituto Studi Romani
nel 1952 e membro del Centro Studi Ciceroniani nel 1957. Nel 1960, dall'Ente
Provinciale per il Turismo di Roma, gli fu data la medaglia d'oro per l'Ode
composta per le Olimpiadi di Roma.
Un altro nome da ricordare è quello di Antonio Viscione,
più conosciuto al pubblico della canzone napoletana nel mondo come Antonio
Vian, nato a Napoli da genitori di Roccabascerana il 14 giugno 1918. Fu grande
musicista e autore di famosissime canzoni napoletane. La sua prima composizione
porta il titolo di "Dormiveglia". Musicò e scrisse canzoni di fortuna come
Luna Rossa (1950), 'O ritratto 'e Nanninella (1955), L'ultimo raggio 'e luna
(1957), Suonno a Marechiaro (1958), Settembre cù me (1960). Scrisse inoltre
in lingua italiana la canzone Il mare. Fondò una casa editrice propria chiamata,
l'ARC, facendosi promotore di spettacoli. E' morto il 22 giugno 1966.
Il Comune di Roccabascerana ha un
proprio gonfalone e uno stemma composti da una
torre in scudo bianco, sovrastato da una corona e con ai lati un ramo di alloro
ed uno di quercia in campo verde-azzurro.
Le rocche e i castelli sono simboli di potenza e questo
stemma con la torre sormontata da due angeli divenne quello ufficiale del
Comune nel 1874 per ricordare le gesta dei suoi avi che si erano battuti per
l’indipendenza dell’Università di quella Torre eretta sulla rocca.
Il Comune comprende i territori delle frazioni
di Rocca, Tuoro, Cassano Caudino, Squillani, Zolli e Tufara Valle entrando
a far parte integrante della Valle Caudina, in quanto si riconosce nella medesima
radice storico-culturale. La stessa comunità locale si ripropone come obiettivo
primario di coordinare i propri programmi con quelli dei paesi vicini di San
Martino Valle Caudina, Cervinara e Rotondi. Lo statuto adottato dal Comune
stabilisce le norme generali per l’ordinamento degli uffici, sulla partecipazione
popolare, sul decentramento, sui procedimenti amministrativi e su quant’altro
demandato dalla Legge si fini della trasparenza. Ultimamente, il Consiglio
Comunale guidato da Natalino Renna ha messo in pratica anche l’articolo dello
Statuto che permette al Civico Consesso di riunirsi anche fuori dall’aula
delle solite adunanze, sedendo nella scuola elementare di Tufara Valle elevata
a sede municipale per un giorno.

 |